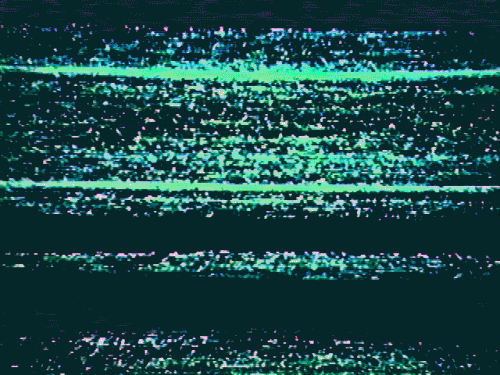SCHERMI
Se
potessi trovarle un difetto. Qualcosa che mi faccia coraggio, qualcosa che l’avvicini
al pianeta terra, all’essere umano…
La
perfezione del suo viso mi mette in imbarazzo. La pelle levigata, la fronte
ampia, gli occhi grandi e distanti, grigi come il cielo al principio del
giorno.
La
curva del mento sotto le labbra a cuore, appena schiuse sulla fila di denti
bianchi, armonizza con il seno sodo e il pendaglio da bigiotteria indica la strada
del paradiso. I capelli scuri si sfogano a onde ampie sulle spalle. Sono sicuro
che profumino di shampoo.
Se
potessi trovarle un difetto.
Ora
sbarazzina, ora fatale, allegra, pensosa.
Un
paio di grossi occhiali di tartaruga la proietta nel mondo degli intellettuali.
Una coppia di bottoni lasciati liberi ed ecco che un poderoso mare di spuma e
vento si materializza alle sue spalle, al termine della spiaggia bianca di
un’isola lontana. Le luci le sono complici. Uscirebbe bene sotto i fasci caldi
delle alogene così come nella livida tristezza di un neon da questura.
Poso
il mio cellulare sul tavolino, accanto al bicchiere di birra che ho bevuto in
tre sorsi per vincere la paura. Lo schermo smorza i colori e poi si spegne.
Ci
dividono sei o sette passi: la rincorsa per un calcio di rigore. Quando muovo
il primo, impacciato, pesante, definitivo come una lapide, i pensieri sono gli
stessi di chi sta per colpire quel pallone che sposterà più soldi di un milione
di operai messi a lavorare alla catena.
Ansia,
paura di fallire, di perdere quell’occasione che non si ripeterà più.
È
alta, con uno slancio di gambe che mortifica lo sgabello al banco del bar. La
gonna plissettata, che termina qualche centimetro sopra le ginocchia, è di un
blu discreto bene abbinato con la camicetta appena più chiara. L’estate è
nell’aria e ormai sono abbastanza vicino da sentire il profumo di buono.
«Ciao.
Mi chiamo Francesco e tu…Tu devi essere Lisa.»
Le
labbra s’increspano per un istante e sì, credo di avere trovato il difetto,
quello che mi mette coraggio. Accanto al suo gomito appoggiato al bancone vedo
un aperitivo rosso, guarnito con una fetta di arancio infilata sul bordo
zuccherato del bicchiere. Il barista, con l’abbronzatura sospetta e le maniche
arrotolate sulle braccia forti, coglie l’importanza del momento e si allontana
col pretesto di raggiungere l’asciugamano appeso.
«E
come conosci il mio nome? Ci siamo già visti da qualche parte?»
La
domanda è legittima e il prezzo da pagare è la mollezza delle ginocchia che
spero non si traduca nella faccia di chi ha urgenza di correre in bagno. L’approccio
è stato da pezzente ma rimedio in fretta.
«Ah,
no. Non ci siamo mai incontrati. Sei…sei fra i miei contatti di Instagram e
anche di Facebook, ecco, e ti ho riconosciuta». Indico il mio smartphone, con
un terzo della base che sporge goffa dal tavolino basso accanto al divanetto. Il
barista palestrato strofina l’interno del bicchiere con le dita infilate nello
straccio e dispensa un sorriso complice. Lisa indietreggia di un passo per
inquadrarmi meglio. Strizza gli occhi, punta il dito e accenna un sorriso
storto. Capisco dallo sguardo birichino che mi ha collocato nella casella
giusta dei contatti social.
«Francesco
Nove Tre?»
Sto
per esplodere di orgoglio. Batto sul petto come Tarzan. «Sono io. Novantatré è
la mia data di nascita.»
«E
dimmi: Francesco è il tuo nome oppure ti sei ispirato a qualche santo?»
«No,
ma che santo? Francesco Maria…»
Ride.
«Maria come la Vergine?»
Sto
perdendo colpi come un motore a fine carriera. Il barista ha portato sul retro
i suoi novanta chili di muscoli e al di là del vetro scorrono le foto di un
pomeriggio in calando. Giacche aperte su cravatte allentate, spalline
scivolose, borsette pesanti e rossetti appena rinnovati. I selfie con i
bicchieri colorati sono d’obbligo e non tutte le fotocamere hanno pietà dopo
una lunga giornata dietro alla scrivania.
«Come
mia nonna…»
«Che
si chiamava Maria?»
Sono
ovvio, prevedibile. Ricordo lo sciacquone alla fine di una pisciata ma
nonostante questo l’incarnazione della bellezza che ho davanti non mi scarta.
Forse la diverto, riempio quei cinque minuti prima che quello davvero figo
arrivi a prenderla. Forse ha un debole per i perdenti e la commuovo come il
tramonto dopo una giornata d’inferno.
«Paghi
tu?» La risposta è sottointesa. Il barista con i pettorali perfetti si cala
nella parte del cassiere, inforca con stile un paio di occhiali dalla montatura
sottile e pesta, sicuro, i tasti del registratore di cassa. «Sono ventitré.»
Mentre
pago, Lisa mi si strofina addosso. Il suo alito caldo trasporta un grazie
appena sussurrato. La mollezza delle ginocchia vira a uno stormo di feroci
farfalle che mi solletica il ventre.
Dietro
lo struscio che consuma il marciapiede, un Aston Martin DB11 taglia la parete
del palazzo come un diamante. È verde acqua di palude, oppure azzurro lago contaminato
di alghe. Dipende da come la guardi.
Seduta
al volante c’è Lisa che mi aspetta.
La
prima dura poco ma sono bravo a salire le scale e a tuffarmi di nuovo nel brodo
caldo della piscina più accogliente del mondo.
Questa
volta ho tempo di dedicarmi ai dettagli: al turgore dei capezzoli che incidono
il petto, alla pelle di seta che mi drizza i peli sulle braccia come una scossa
elettrica, all’andirivieni del ventre, che sale e scende, e sale e scende come una
nave con le vele gonfie che ha guadagnato il mare aperto.
La
bottiglia di Louis Roederer da duemila euro è pronta a fare saltare il tappo
per accompagnare le tartine col caviale di grana grossa. La finestra della
camera abbraccia il luccichio sulla superficie del mare che anticipa il calare
del sole.
È
un sogno, di quelli da sfogliare come un album di fotografie.
Lisa
non si risparmia e respira. Respira e pare voglia accumulare tutta l’energia
del mondo per esplodere come una bomba nucleare. La cosa certa e che io salterò
in aria assieme a lei.
La
casa è un edificio moderno, basso, dall’architettura essenziale. É comparsa
alla fine di una stradetta in terra bianca che attraversa un bosco di pini arresi
ai capricci del vento e mi ha accolto con un monolocale di pavimenti lucidi,
high tech e quadri astratti alle pareti. Il tetto con le travi a vista, solo
lievemente inclinate, è interrotto dal camino in pietra al centro dello spazio,
anticipato da un ampio divano e da un tavolo in vetro pronto per fare festa. La
porta sulla parete al fondo è aperta su un bagno sontuoso e sulla camera da
letto. Già sapevo che vi avrei passato un momento indimenticabile.
Quando
il cuore comincia a rallentare, noto lo schermo appeso alla parete. È un ventisei
pollici lcd, montato su un supporto orientabile. Inquadra dall’alto un bambino
di forse due anni. Dorme nel suo lettino con un braccio pizzicato sotto il viso
e i capelli lunghi e biondi sparsi a ventaglio sul cuscino azzurro. Mentre Lisa
ancora cerca il ritmo naturale del suo respiro, il piccolo mostra la serenità
degli innocenti. Non faccio in tempo a domandare, quando lei mi anticipa.
«Si
chiama Martino. Compirà due anni a settembre. L’ho avuto con Valerio, il mio
primo marito…»
Mi
chiedo chi sia il secondo marito e anche questa volta mi legge nel pensiero.
«Il secondo non esiste. Oddio, arriverà, anche perché l’angioletto ha bisogno
di un papà, ma per ora nulla. Diciamo che sono alla ricerca del candidato
ideale…»
Il
pargolo è stupendo.
Si
rincorrono pensieri tossici, distruttivi. Lisa deve avere avuto un marito bello
come un dio. Mi aspetto un confronto impietoso, fra muscoli, intelligenza,
personalità e virtù meno apparenti. A pensarci bene sono anche un discreto
morto di fame e il portafoglio sanguina ancora dopo che ho pagato l’aperitivo e
invece, a quanto pare, Lisa ha un tenore di vita che non mi appartiene. Sento
ancora le vibrazioni della Aston Martin che si propagano nel fondoschiena. Do
fiato alla bocca senza riflettere troppo.
«Potrei
essere io?»
Lo
sguardo è di quelli che ti aspira tutto il sangue e lo sistema in ghiaccio in
fondo al freezer. Mi sento come il pesce nell’acquario, come l’insetto
catturato dal bambino senza cuore e lasciato consumare di fatica sul fondo del
barattolo. «Cosa?»
«Il
candidato ideale…»
Lisa
rannicchia le ginocchia. Mi sfiorano le gambe nude e sento che la manovella
ricomincia a girare. Ricevo il bacio e mi giro per vedere il bambino in Tv.
Come la mamma, ha cambiato posizione. Ora dorme supino, con la bocca che sembra
divorare il cuscino.
«Potresti,
perché no! Il primo colloquio, direi, è andato bene e il secondo…»
Riesco
ancora a parlare prima di essere soffocato da un bacio. Finisce dopo
un’eternità mentre la mano di lei ingrana la marcia. «Colloquio? Non mi sembra
che abbiamo parlato…»
Sospira.
«Era la prova pratica. Dopo mangiato partiamo con le interrogazioni. Ti va bene
il programma?»
Mi
piace il programma e mi piace come bacia. Piace alla mia parte animalesca che
comincia a scalpitare come un cavallo nel temporale.
Il
cellulare di Lisa vibra sulla superficie in marmo del tavolino e tutti i
contatti vanno in corto. Smetto quello che ho cominciato e smonto da cavallo.
Lei, colta da un’improvvisa pudicizia, si tira il lenzuolo al mento e risponde.
È
una chiamata video.
Lo
schermo incornicia un volto da maschio alfa: mascella importante, barba sale e
pepe trascurata con sapienza, occhi neri e severi come quelli di un comandante.
Lisa si scusa con un po’ d’imbarazzo.
«È
Valerio, il mio ex marito.»
Mi
chiedo quanto tempo impieghi per spettinarsi così bene e perché la clavicola
inquadrata al fondo del display ricordi il ferro battuto dei cancelli. La voce
da doppiatore di divi è all’altezza delle aspettative.
«Ho
disturbato? Hai ospiti?»
La
risposta è lapidaria. «No, sbarra sì. A cosa devo la tua apparizione?»
«Domani
sarà vento. Forte. Con Gigi e la Sabri si era deciso di andare a vela. Se gira
giusto, anche la Micky e Beppe sono dei nostri. Te?»
Spero
che Lisa mi consulti ma tutto sommato è meglio che non lo faccia. Come marinaio
non valgo nulla e credo che cadrei a mare alla prima virata. A dirla tutta mi
fa paura qualsiasi liquido che si agiti poco più dei gargarismi con il sale o
dell’aspirina che rotola in mezzo bicchiere d’acqua. Avrei risposto di no
davanti al dio greco per disintegrarmi subito dopo dietro quel sorriso da
macho.
«Bravo
te. E che ci faccio con Martino?»
Questa
vota la voce del maschio alfa non maschera la commozione. «Il pupo come sta. Se
la cava?»
«Corre
come un treno, gioca, mangia e caga ma direi che è ancora presto per lasciarlo
solo con qualcosa da scaldarsi al microonde e un porno da guardare sul web…»
Effettivamente
il bimbo è speciale. Sbadiglia e si strofina gli occhi, ancora assonnati nel
bel mezzo di quella faccia seria. Non mi stupirei se stesse pensando a una
riunione d’affari. Lisa, invece, parla con lo schermo con lo stesso trasporto
che avrebbe dinanzi a una persona in carne e ossa. Valerio non desiste:
«Non
lo lasci solo. Chiami la baby sitter e la metti sotto a cambiare pannolini…»
Quando
finalmente Lisa si gira alla ricerca del mio consenso, ho abbandonato il
materasso e attraversato a piedi nudi la grande camera. Guardo fuori coprendomi
le grazie con la mano e mentre un alone di condensa si forma attorno al naso
schiacciato sul vetro . Non c’è modo di uscire sulla terrazza in pianelle blu
che si affaccia sulle onde. Il cristallo, che occupa l’intera parete, è
ammorsato nei muri e nel pavimento come una diga nel granito. Il mare si sta
contaminando con qualche goccia di nero e il cielo comincia ad appesantirsi.
Lisa mette in attesa l’ex marito. Con il lenzuolo addosso, sculetta fino al
computer in standby sulla scrivania e chiama la baby sitter.
Risponde dopo una serie di cicalii che
ricordano un piccione in amore.
È asciutta come un ramo in inverno e
invasa dall’azzurro degli occhi formato extraterrestre. I capelli appaiono
scuri per effetto del bagnato ma sono biondi e incollati al volto. Non vedo
l’asciugamano intorno al collo ma è certo che sia appena uscita dalla doccia.
Il piercing al naso balugina nell’inquadratura della web cam come se
catturasse la luce ritmica di un lampeggiante. Scopro dopo un attimo che si
chiama Claudia.
Lisa si siede sul bordo della sedia, blocca il lenzuolo sul
petto con la mano e chiede alla baby sitter se abbia tempo e modo di prendersi
in carico il piccolo Martino quando lei, l’ex marito Valerio e la serie di
amici sportivi e pronti ai tutto si
sollazzeranno fra i marosi salati nel sole che scotta. Intanto il bambino ha
ingaggiato una lotta con le lenzuola e pare si arrampichi in parete nelle
Dolomiti del Cadore.
La trattativa dura poco.«Ma
certo, Lisa, lo terrò con me tutto il tempo necessario» dice, e Lisa la ripaga
con quel sorriso che ho imparato a conoscere.
Decido
di rivestirmi.
La
finestra sul terrazzo è ostile, sigillata come una bara e le mie nudità mi
mettono in imbarazzo. Valerio, l’ex marito, è sempre inquadrato nello schermo
del cellulare. Si trastulla la barba, fa smorfie e spinge le labbra con la
lingua fino a quando la punta non fa capolino. Passo, evitando di finire
nell’inquadratura e vado oltre. Ci sono cose dopo il sesso che vanno fatte
subito, tipo fumare e cambiare l’acqua al pesce. Ricordo di avere lasciato le
sigarette sull’Aston Martin.
La
conversazione fra le due si è fatta fitta.
Si
parla del tempo, del mare, del catamarano tredici metri che dondola placido
nelle acque del porticciolo, delle rispettive avventure amorose. Claudia
accenna a un tipo che le ricorda il dio del mare, Lisa ride ma tarda a
raccontarle di me. Il piccolo Martino, a video, ha litigato con le lenzuola al
punto che lo avvolgono come un sudario.
La
sala bagno non delude, solo un po’, per così dire, solenne. Sopra il lavandino
doppio, la specchiera è ricavata all’interno di una profonda nicchia. Nessun
mobiletto o tappeto. Il box doccia con il piatto di legno è del tutto
trasparente, l’ampia vasca con idromassaggio troneggia al centro del pavimento
in severo marmo grigio con le striature bianco ossa. Lo stesso rivestimento è
utilizzato per le pareti.
Mentre
Lisa e Claudia se la ridono nella loro videoconferenza, svuoto la vescica, apro
l’acqua della doccia e mi tuffo dentro un muro di vapore.
Che
mi coccola, mi rigenera.
Scioglie
le tensioni e purifica la pelle. Sono all’interno di un universo parallelo, mi
sembra di viaggiare su un disco volante.
Il
docciaschiuma blu mare profuma di salsedine. Cola sul petto, sulle gambe e
forma una patina azzurrognola che solletica i piedi,
Mi
concedo un secondo giro e intuisco fra l’andirivieni del vapore che Lisa sta
riempiendo la vasca dell’idromassaggio.
Ha
raccolto i capelli in un chignon, la frangia è divisa in modo impari:
abbondante sulla sua sinistra fino a coprire l’occhio, ridotta a un ciuffo di
capelli meno consistente dalla parte opposta del viso. Immersa nell’acqua che
ribolle e schizza sul viso, è seria quanto basta per preoccuparmi.
«Tutto
bene, Lisa? Ti sei messa d’accordo con Claudia?»
Non
risponde. Sprofonda sotto le bolle. Temo di averla offesa. Ho indossato
l’accappatoio da uomo che era appeso accanto al suo microfibra e forse ho
ecceduto in confidenza. Riemerge dopo quasi un minuto.
È
affannata.
L’acqua
le cola dalle narici e il chignon si è disfatto in una serie di trecce
disomogenee appiccicate alle spalle e sui seni. Senza farmelo chiedere, levo
l’accappatoio e lo rimetto al suo posto. Nudo come un verme non sono autorevole
ma ci provo comunque:
«Lisa,
è stato bellissimo. Ora…ora torno di là, mi rivesto e poi vado. Allora, in
bocca al lupo per la gita col catamarano…»
Lei
sputa l’acqua che aveva inghiottito. Ha gli occhi arrossati come dopo un lungo
bagno in mare.
«Ma
no! Ci sono lo champagne e le tartine di caviale. Non te ne vai senza prima avere
bevuto qualcosa. Ti pare?»
«Sarebbe
un peccato dire di no al Louis Roederer…»
Indugia.
Con un colpo di tosse espelle ancora acqua, dal naso e dalla bocca. Il sorriso
è appena accennato, andrebbe interpretato fra le righe di quel volto
bellissimo. «Lo beviamo qui. Vai a prenderlo…»
E
torno in camera. La pelle calda per il vapore si scontra con l’aria mite
dell’ambiente. Ancora il mare che lentamente affonda nel buio, il letto
disfatto, le lenzuola abbandonate in terra sulla strada del bagno. Il volto di
Claudia, l’amica baby sitter di Lisa, è rimasto impresso nello schermo del
computer. Sono colpito dalla fissità dello sguardo, dalla pelle diafana, dal
tracciato azzurro delle vene che s’intravede sotto le sacche edematose alla
base degli occhi. L’aria mite della stanza vira al gelo.
Mi
avvicino.
Claudia
sembra morta ma mi sorprende vomitando un getto d’acqua misto a materia scura e
molliccia.
Alghe.
Il
secondo conato è ancora peggiore e imbratta la videocamera. Il suono profondo e
gutturale si apparenta con un lamento infernale.
Sono
nudo, il sesso ridotto al nulla, le gambe tremule. La paura.
Valerio,
inquadrato nel cellulare ancora acceso di Lisa, è morto. Ha i capelli
appiccicati al cranio, le palpebre socchiuse sopra le pupille fisse, le labbra
gonfie e violacee. Mi avvicino quanto basta per comprendere che lo sfondo nero
dietro alla sua testa è un sacco per i cadaveri e quasi svengo quando, con un
solo gesto netto, deciso come la lama di una ghigliottina, una mano anonima
tira la cerniera lampo chiudendo il sipario sulla scena.
Lo
schermo sedici pollici appeso al muro pare il vetro di un acquario. Ci sono
bolle grandi e piccole attaccate alla superficie, bolle che risalgono e una
nuvola di sporco che galleggia informe nel centro della scena.
Acqua.
Vorrei
urlare ma il grido s’incastra fra le tonsille e quello che ottengo è una tosse
convulsa e sento freddo. Il buio dietro la finestra ha conquistato il mare e un
cielo povero di stelle pesa come il coperchio di un tombino.
Voglio
tornare da Lisa, avvertirla di quello che accade ma ho i piedi praticamente
incollati al pavimento.
Quando
vedo il corpo esanime del bambino che galleggia nello schermo con le braccia
spalancate, cado in ginocchio come se mi avessero fucilato.
Non
so come, ma torno in bagno.
La
vasca dell’idromassaggio ribolle come un vulcano e la mano di Lisa ha spezzato
le unghie nel tentativo di uscire. Ora è immobile, rivolta verso terra con il
polso piegato sul bordo.
Il
mio telefono funziona ancora.
Non
sento più freddo, né dolore.
Nudo,
senza la forza e il costrutto di rimettere insieme i pezzi della mia anima, mi
collego al social network e la vedo lì, meravigliosa. Ora con gli occhiali da
intellettuale, ora con la sabbia della spiaggia maliziosamente appiccicata ai
glutei sodi. Ora vestita a festa per il battesimo del piccolo Martino. Nella
foto di gruppo compaiono tutti: Lisa, Valerio, il piccolo, Claudia e tutti gli
altri amici.
Capisco
solo dopo che sono affogati in mare, morti, travolti un anno prima da un’onda
anomala improvvisa. Per i social network, invece, e per la mia infinita
ingenuità, Lisa continuava a esistere.
Con
il tempo ho trovato l’animo di rivestirmi ma gli schermi non hanno finito di
torturarmi. Le scene si perpetuano, le morti si ripetono.
È
impossibile uscire dalla casa.
Se
mi affaccio alla finestra sul mare, dove si avvicendano i giorni e le notti, se
mi avvicino alle altre finestre sparse per la casa, vedo gli occhi curiosi che
convergono verso la mia disperazione e i pollici enormi che scorrono
sull’esterno del vetro e scrollano, scrollano.
Scrollano.
Sono
morto ma non cancellato.
Continuo
a esistere, sigillato dentro un social network come un pesciolino fra le pareti della sua boccia di vetro.
© Diritti riservati








.gif)
.gif)